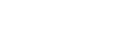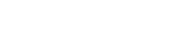Giuseppe Alinovi
(Parma, 1811 – 1848)
Borgo del Naviglio
1840 post – 1845 ante, olio su tavola
Il dipinto che presentiamo oggi ci permette da un lato di capire la complessa toponomastica delle strade cittadine e dall’altro di conoscere l’antico mestiere della lavandaia. Questa veduta di Alinovi, che raffigura il fronte posteriore delle abitazioni che danno sull’attuale borgo del Naviglio, ci permette di capire come fosse strutturato l’antico sistema di ponti e di acque, già evidente negli intarsi Quattro e Cinquecenteschi delle sagrestie dei Consorziali e dei Canonici del Duomo di Parma; raffigura la confluenza dei due principali canali cittadini, il “Comune” a sinistra e il “Maggiore” a destra, nel tratto finale del loro percorso urbano presso il borgo ancora oggi denominato ‘del Naviglio’.
Parma, in epoca medievale, era attraversata da un gran numero di corsi d’acqua: canali primari e secondari, piccole canadelle, fossi di varia grandezza e semplici scoli, che formavano una fitta rete di percorsi che si intersecavano con le strade e le piazze della città.
L’acqua ‘corrente’ era indispensabile per molteplici usi: per alimentare il fossato che circondava le mura, ma anche come forza motrice per i mulini e per i vari opifici (conciatori, cartolari, tintori), oltre che per le attività artigianali e manifatturiere (beccai, arte della lana); infine era utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti e per l’irrigazione degli orti.
Nel corso del XII e XIII secolo il Comune di Parma aveva potenziato l’erogazione d’acqua cittadina predisponendo lunghi canali che, partendo dalle sponde del torrente Parma a sud di Langhirano e a monte di Lesignano, arrivavano in città diramandosi in una serie di condotti secondari che attraversavano i vari quartieri.
In città, sulla sponda destra del torrente, nel cuore della città vecchia, due erano i più importanti condotti: il canale ‘Maggiore’ e il canale ‘Comune’ che si univano presso porta Santa Maria o Pediculosa, e poi porta Nuova, sulla strada dei Genovesi (oggi strada Farini) e si dividevano al «partitore», in prossimità di borgo del Becco (borgo Riccio da Parma). Il ‘Maggiore’ portava acqua ai due mulini del convento di Sant’Uldarico, percorreva borgo del Becco, raggiungeva quindi i mulini di strada San Quintino (strada XXII Luglio), ove si trova l’odierno borgo del Canale, proseguiva verso la chiesa di Santa Cristina, scorrendo poi per borgo Riolo (strada Cairoli), borgo Pipa e borgo Retto. In seguito il corso del canale fu deviato dal Riolo al complesso episcopale scorrendo sotto il seminario Maggiore, il Battistero – il fonte battesimale era approvvigionato direttamente dal canale – e dare movimento al mulino del vescovo, per poi ritornare in borgo Pipa e portare acqua al mulino e agli orti del monastero benedettino di San Giovanni Evangelista. Il ‘Comune’ proseguiva per la strada dei Genovesi, attraversava piazza Grande (piazza Garibaldi) e, superata Pescheria Vecchia (piazzale Cesare Battisti) e piazzale della Macina, proseguiva lungo strada Santa Lucia (strada Cavour), passando sotto l’omonima chiesa, un tempo conosciuta come San Michele del Canale, per raggiungere il mulino del convento di San Paolo e uscire quindi da borgo delle Asse (coperto da tavole di legno). Verso l’inizio di borgo del Naviglio, nell’estremo limite nord-est della cinta muraria, i due canali si ricongiungevano per formarne uno solo che usciva dalla città: il ‘Naviglio’, noto fin dal XII secolo come idrovia per Coenzo e poi per Colorno, attraversando Paradigna, Cortile San Martino, Pizzolese e Gaiano. Scavato nel 1283 e riscavato in seguito da Margherita Farnese nel 1628, il canale non era, tuttavia, più navigabile già nell’Ottocento – quando costituiva uno dei rari elementi scoperti del ramificato sistema di corsi d’acqua un tempo esistenti in città e poi ricoperti o interrati nei successivi risanamenti otto e novecenteschi.
Il Naviglio e il suo borgo con i suoi inconfondibili scorci caratterizzati da ponti e ponticelli fu particolarmente apprezzato dai pittori locali. Non a caso il soggetto fu scelto dall’Accademia di Belle Arti di Parma quale tema del concorso di paesaggio dal vero nel 1862, vinto a pari merito da Camillo Scaramuzza e Adelchi Venturini.
Anche Giuseppe Alinovi, allievo della scuola di Paesaggio di Giuseppe Boccaccio, fu affascinato da quella particolare atmosfera che contraddistingue da sempre questa zona, simbolo della città vecchia. Sono note due opere dell’artista – Ponte sul Naviglio e Borgo del Naviglio – memorie di una vita semplice, probabilmente misera, ma altrettanto autentica.
Alinovi non ottenne mai riconoscimenti ufficiali in campo accademico, ma, grazie al suo personalissimo stile pacato e intimo, seppe far breccia nell’animo della duchessa Maria Luigia, grande appassionata di paesaggi, per la quale eseguì nel 1839 un libro di vedute paesistiche sulle strade di Parma e di Pontremoli.
Fu comunque artista di gusti semplici; seguendo i dettami del Vedutismo di primo Ottocento, predilesse, vedute di piccoli borghi e paesi con le loro modeste piazze, i casolari dispersi nei campi, le acque correnti di ruscelli e canali, dai quali, attraverso una ricerca poetica di aria e di luce, seppe cogliere l’incanto segreto. Non si allontanò mai troppo dai dintorni della provincia, eppure nel suo mondo a limitato raggio, seppe afferrare la riposta poesia delle cose esprimendola con un linguaggio limpido ed efficace.

Verso il 1840 l’artista dipinse il primo tratto del canale Naviglio, in uscita dalla città: l’immagine pittorica ha fissato i caratteri salienti delle povere case, apparentemente diroccate, dal profilo mosso, allineate lungo il borgo quando erano ancora presenti gli archi “lanciati” per collegare, ad altezza d’uomo, le opposte facciate e, al contempo, l’attività delle operose lavandaie che popolavano il rione. Documentò così con forza il degrado e la miseria dei borghi della città, oggetto degli interventi assistenziali della duchessa Maria Luigia fin dal suo arrivo a Parma nel 1816.
La ripresa leggermente scorciata dal basso, ricorrente in molte vedute di Alinovi, dà slancio agli edifici che sembrano, però, incombere con la loro mole sulle figure dei lavoratori, stretti in un breve tracciato lungo appena 167 metri e largo mediamente poco più di 8 metri.
L’effetto vedutistico è accentuato da un’abile scansione prospettica di passaggi e archi che, attraverso un sapiente bilanciamento di luci e ombre, danno rilievo alla composizione articolata entro il lungo cannocchiale della strada.

Il punto di vista del pittore potrebbe oggi indicarsi nel basso cortile di fronte al passaggio voltato che, della prima casa a sinistra nel quadro – fra borgo del Naviglio e borgo degli Studi, porta nella parte posteriore della strada, prorpio accanto alla facciata laterale dell’antico palazzo Cusani oggi sede della Casa della Musica e nel 1778 destinata dal duca Ferdinando I di Borbone a zecca di Stato e la cui macchina era mossa dal canale Maggiore, che piegava proprio dietro il palazzo.

La vita delle lavandaie era durissima, costrette a lavare i panni nei fiumi o nei canali con le mani nell’acqua d’inverno, dopo aver spaccato il ghiaccio di superficie, o fra i miasmi dei canali cittadini, d’estate. Il loro lavoro cominciava alle prime ore del giorno e finiva al tramonto. Arrivavano al canale spingendo carriole di legno colme di biancheria. I panni sporchi (panni brutti), raccolti presso le case signorili dalle stesse lavandaie, venivano trasportati sulle forti spalle delle donne, dentro sacchi di iuta contrassegnati da nastrini colorati.

L’abbigliamento povero delle lavandaie era caratterizzato dal fazzoletto legato sul capo, che si dice derivi da una antica rivendicazione di un fazzoletto di terra, a loro promesso in passato e mai concesso, e dalle lunghe gonne con l’orlo rialzato, spesso inserito nella cintura, una precauzione necessaria per evitare che si inzuppassero d’acqua.

Gli strumenti del mestiere erano tanti: il sapone solido a pezzi, la cenere di legna, la tavola da lavare, il colatoio (vaso di terracotta, forato in basso), il mastello in legno, il telo di canapa (ceneraccio), la brocca, la conca, la caldaia, il fornello, il mestolo di metallo (cazza), il bastone di legno biforcuto.
I panni sporchi venivano lavati al canale con il sapone solido tagliato a blocchetti, quindi venivano sciacquati e strizzati. In questo modo erano già puliti ma non sbiancati. Perciò successivamente venivano messi in un mastello di legno foderato da un panno. Sul fondo del mastello era presente un foro, chiuso da un tappo, in modo da poter far fuoriuscire l’acqua. Sistemato il panno nel mastello vi si adagiavano sopra i panni, mettendo tra uno strato e l’altro qualche foglia di alloro per profumarli. In un caldaio a parte si metteva a bollire l’acqua insieme alla cenere e si lasciava bollire per qualche minuto. Poi si lasciava “posare” il tutto in modo che la cenere si depositasse sul fondo. A questo punto l’acqua in superficie veniva raccolta con una piccola brocca con il manico e versata nel mastello sopra i panni, coperti con un telo, per evitare che insieme all’acqua potesse cadervi sopra anche un po’ di cenere. I panni erano lasciati a riposo nel mastello per tutta la notte. Il mattino successivo, si toglieva il tappo dal fondo del mastello per permettere all’acqua di fuoriuscire.

Quindi si toglievano i panni dal ceneraccio, si scrollavano, si risciacquavano e infine si stendevano al sole, finalmente bianchi e profumati.
Il mestiere di lavandaia era appannaggio femminile; i mariti le aiutavano a trasportare il bucato e gli strumenti del lavoro, a stendere i panni, a portare la biancheria appena lavata alle famiglie dei clienti.

Scheda realizzata in collaborazione con Artificio Società Cooperativa